Rubriche
Le Interviste di FinPA
Interviste su Amministrazione e Finanza Pubblica
Intervista a Vittorio Raeli
Intervista n. 3/2025 a
VITTORIO RAELI
Presidente di Sezione della Corte dei conti
Parte I: Esperienza e aneddoti …
- Come si è avvicinato allo studio della finanza e della contabilità pubblica? Cosa le ha interessato, in modo particolare, di questo ambito?
Mi sono avvicinato allo studio della contabilità e della finanza pubblica in occasione della preparazione del concorso di accesso alla magistratura contabile anche perché di formazione universitaria sono un civilista e, quindi, il mondo della finanza pubblica era molto lontano, sin dai tempi dell’Università, dagli interessi di studio. Ciò che mi ha interessato sin da subito è il profilo della tutela delle finanze pubbliche. 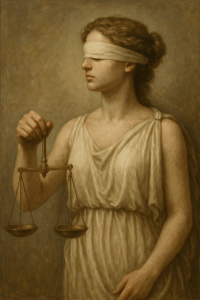
2. Ai tempi della sua carriera universitaria, veniva prestata attenzione alla contabilità pubblica?
Il corso di studi della facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Pisa, dove ho conseguito il diploma di laurea – se non ricordo male – non prevedeva l’insegnamento della materia allora denominata “Contabilità di Stato”, che, invece, era prevista dal programma del corso di laurea della facoltà di Scienze Politiche. Qui vi insegnava come “libero docente” (figura ormai scomparsa nell’ordinamento universitario) un magistrato della Corte dei conti, Antonio Bennati, ed è sul libro da lui scritto che ho preparato le prove di esame del concorso per l’accesso alla magistratura contabile.
3. Cosa l’ha portata ad intraprendere la carriera presso la Corte dei conti? C’è qualche speciale aneddoto che vorrebbe raccontarci al riguardo?
Ero già magistrato (militare) quando maturai il convincimento che non avrei trascorso i futuri anni lavorativi a trattare di reati militari ed ebbi l’occasione di conoscere un consigliere della Corte dei conti, parente di una mia zia, al quale chiesi informazioni circa il concorso e la difficoltà – di cui tanto si parlava – dello stesso. Ci saremmo rivisti, poi, in occasione del ritiro di un plico contenente tutti i temi che da quarant’anni erano stati dati al concorso e fu da lì che iniziò il mio percorso di studi. Trovavo ostica soltanto la parte relativa al bilancio dello Stato che decisi di approfondire quanto basta per sostenere una prova dignitosa, ben consapevole dei miei limiti. Fortuna volle che agli scritti non uscì il tema relativo al bilancio, ma quello relativo al riparto di giurisdizione in ipotesi di danno agli enti pubblici economici, che era a me più congeniale. La dea bendata aiuta gli audaci, ma forse sarebbe il caso di dire che aiuta gli incoscienti quale fui!
Parte II: La Corte dei conti ieri ed oggi
4. Se dovesse attribuire due diverse definizioni al ruolo della Corte dei conti svolto, rispettivamente, negli anni Settanta-Novanta del secolo scorso e nel nuovo secolo (più o meno a partire dal 2000), quali caratteri metterebbe in evidenza di queste due periodizzazioni? Cosa è più radicalmente cambiato tra la Corte di quel tempo e quella di oggi, a suo giudizio?
Le funzioni intestate alla Corte dei conti, sin dai tempi della sua istituzione, nel 1862, quale prima magistratura del Regno d’Italia, sono da sempre ascrivibili all’area del controllo e della giurisdizione. La funzione consultiva già prevista dagli anni ’30 del secolo scorso ha avuto, infatti, una espansione soltanto nel 2003 con la legge n. 131, recante disposizioni di adeg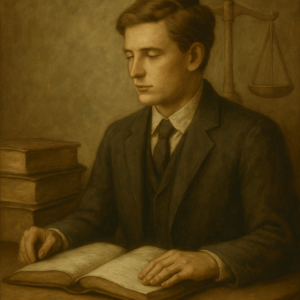 uamento al mutato quadro ordinamentale derivante dalla riforma costituzionale del 2001. Ciò detto, è inevitabile che i mutamenti istituzionali e normativi che sono scaturiti nel corso di oltre un secolo abbiano avuto un impatto sulla attività della Corte dei conti, sebbene verso la fine del secolo scorso siano state varate due importanti riforme che riguardano il controllo e la giurisdizione. Grosso modo si può dire che, fino al 2000, le funzioni di controllo si bipartivano in controllo preventivo di legittimità e successivo sulla gestione di tutte le amministrazioni pubbliche. Con la legge finanziaria del 2005, infatti, irrompe sulla scena normativa un terzo tipo di controllo, in considerazione della necessità di rispettare i vincoli finanziari europei, che, per convenzione, possiamo chiamare controllo contabile-finanziario, al quale, nel 2012, viene attribuito lo stigma sanzionatorio, in quanto gli esiti negativi dello stesso possono determinare il blocco dei programmi di spesa soprattutto degli enti locali. Anche la giurisdizione è cambiata, intanto perché la responsabilità amministrativa è profondamente mutata rispetto alle origini, per l’accentuazione del carattere personalistico della stessa e la dilatazione della nozione di rapporto di servizio, e, poi, perché il radicamento sul territorio delle procure e delle sezioni giurisdizionali regionali ha dispiegato nel nuovo secolo tutte le sue potenzialità in termini di “controllo diffuso” delle amministrazioni pubbliche: le procure regionali sono tenute ad aprire un fascicolo istruttorio in presenza di un esposto anche anonimo.
uamento al mutato quadro ordinamentale derivante dalla riforma costituzionale del 2001. Ciò detto, è inevitabile che i mutamenti istituzionali e normativi che sono scaturiti nel corso di oltre un secolo abbiano avuto un impatto sulla attività della Corte dei conti, sebbene verso la fine del secolo scorso siano state varate due importanti riforme che riguardano il controllo e la giurisdizione. Grosso modo si può dire che, fino al 2000, le funzioni di controllo si bipartivano in controllo preventivo di legittimità e successivo sulla gestione di tutte le amministrazioni pubbliche. Con la legge finanziaria del 2005, infatti, irrompe sulla scena normativa un terzo tipo di controllo, in considerazione della necessità di rispettare i vincoli finanziari europei, che, per convenzione, possiamo chiamare controllo contabile-finanziario, al quale, nel 2012, viene attribuito lo stigma sanzionatorio, in quanto gli esiti negativi dello stesso possono determinare il blocco dei programmi di spesa soprattutto degli enti locali. Anche la giurisdizione è cambiata, intanto perché la responsabilità amministrativa è profondamente mutata rispetto alle origini, per l’accentuazione del carattere personalistico della stessa e la dilatazione della nozione di rapporto di servizio, e, poi, perché il radicamento sul territorio delle procure e delle sezioni giurisdizionali regionali ha dispiegato nel nuovo secolo tutte le sue potenzialità in termini di “controllo diffuso” delle amministrazioni pubbliche: le procure regionali sono tenute ad aprire un fascicolo istruttorio in presenza di un esposto anche anonimo.
5. Quali sono le principali difficoltà che oggi la Corte dei conti vive nell’esercizio delle sue funzioni, e, in particolar modo, di quella giurisdizionale?
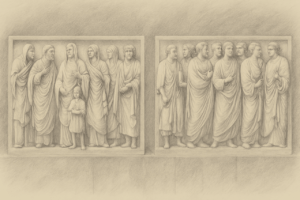 In disparte le difficoltà di carattere organizzativo, ascrivibili anche alla deficitaria gestione del personale di magistratura da parte dell’organo di autogoverno, che non rispetta i suoi deliberati in materia di programmazione quadrimestrale dei concorsi interni per la copertura dei posti vacanti, vi è da dire che manca nel legislatore una visione di lungo periodo, preferendosi cavalcare l’emergenza reale o supposta che sia. Mi riferisco, in particolare, alla iniziativa legislativa in corso in sede parlamentare tesa a modificare per l’ennesima volta la disciplina della responsabilità amministrativa e che dovrebbe cercare di risolvere il problema della “burocrazia difensiva” ovvero della “paura della firma”, per usare un gergo giornalistico. Un tentativo maldestro, che è volto più che a riformare a “controriformare” la Corte dei conti attraverso una “truffa delle etichette”. Se, come è probabile, la “controriforma” supererà indenne l’esame parlamentare, diventando legge, i giudici contabili si troveranno costretti ad irrogare sanzioni in forma di risarcimento per valori irrisori, con buona pace per la tutela delle finanze pubbliche.
In disparte le difficoltà di carattere organizzativo, ascrivibili anche alla deficitaria gestione del personale di magistratura da parte dell’organo di autogoverno, che non rispetta i suoi deliberati in materia di programmazione quadrimestrale dei concorsi interni per la copertura dei posti vacanti, vi è da dire che manca nel legislatore una visione di lungo periodo, preferendosi cavalcare l’emergenza reale o supposta che sia. Mi riferisco, in particolare, alla iniziativa legislativa in corso in sede parlamentare tesa a modificare per l’ennesima volta la disciplina della responsabilità amministrativa e che dovrebbe cercare di risolvere il problema della “burocrazia difensiva” ovvero della “paura della firma”, per usare un gergo giornalistico. Un tentativo maldestro, che è volto più che a riformare a “controriformare” la Corte dei conti attraverso una “truffa delle etichette”. Se, come è probabile, la “controriforma” supererà indenne l’esame parlamentare, diventando legge, i giudici contabili si troveranno costretti ad irrogare sanzioni in forma di risarcimento per valori irrisori, con buona pace per la tutela delle finanze pubbliche.
6. Come si rapporta, oggi, la funzione di controllo della Corte rispetto a quella giurisdizionale? La prima può essere ancora considerata “figlia di un Dio minore”, rispetto alla seconda, ricordando il titolo di uno scritto di G. Caianiello (G. CAIANIELLO, La Corte dei conti in convegno, e i figli di un dio minore, in Foro amm.-CdS, 2006, 2370)?
Sono trascorsi esattamente venti anni da quando Girolamo Caianiello coniava quella espressione ed i tempi sono cambiati perché la funzione di controllo ha avuto dal legislatore quella attenzione che si meritava e che è frutto della emancipazione dal modello tradizionale, imperniato essenzialmente su valutazioni di stretta legittimità, non essendo mai veramente decollato il nuovo modello del controllo (concomitante e successivo) sulle gestioni pubbliche. La figura del controllo contabile-finanziario di nuovo conio sta a dimostrare quanta strada è stata fatta sul versante delle riforme della funzione di controllo. Manca, però, un ultimo tassello rappresentato dal varo di un “codice” che è oggetto della disposizione di delega prevista dal disegno di legge attualmente in discussione al Senato. Vi è da segnalare, purtroppo, il tentativo nella stessa sede parlamentare di strumentalizzare il controllo preventivo di legittimità, in quanto quel disegno di legge introduce tre nuove cause di esclusione della responsabilità amministrativa collegate alla registrazione dell’atto ovvero al decorso del termine previsto come perentorio per l’esame dello stesso da parte della Corte dei conti, secondo il meccanismo tipicamente amministrativo del c.d. silenzio-assenso. L’intento della maggioranza di governo – si dice – è quello di combattere la “paura della firma”, ma il vero proposito è quello di introdurre nell’ordinamento nuove sacche di immunità che riguardano amministratori e dipendenti pubblici.
Parte III: La dimensione sovranazionale
7. La sua esperienza nella giurisdizione militare l’ha portata a operare in un ambito istituzionale che per lungo tempo ha sofferto i vincoli della spending review. Oggi, al contrario, l’Unione europea si muove verso la creazione di una difesa comune, anche attraverso programmi come il RearmEU. Come valuta questa inversione di tendenza? Quale ruolo, in particolare, potrebbero assumere le Corti dei conti – nazionale ed europea – in questo nuovo scenario?
Come è noto, il piano ReArm Europe è passato nel Consiglio dell’UE, che è composto dai Ministri di ciascuno Stato membro, ma senza i voti del Parlamento europeo, in quanto la Presidente della Commissione UE si è avvalsa dell’articolo 122 del TFUE, che prevede un procedimento accelerato nei casi, tra gli altri, di “grave difficoltà nell’approvvigionamento di determinati prodotti”. E, inoltre, la Corte dei conti europea ha espresso, in una nota, una serie di preoccupazioni sulle modifiche proposte dalla Commissione al quadro della politica di coesione 2021-2027 in relazione alla riassegnazione delle risorse alla difesa. In ambito nazionale, per le spese militari il governo pensava di introdurre nel decreto legge infrastrutture, in sede di conversione, un emendamento con il quale velocizzare gli acquisti di materiale ed equipaggiamento necessari per far fronte alle carenze di capacità difensive dell’Italia, escludendo sui relativi contratti il controllo della Corte dei conti per affidarlo ad una “commissione speciale” composta da un consigliere di Stato, da un avvocato dello Stato, da un rappresentante per ciascuna Forza armata e da un rappresentante della Direzione nazionale degli armamenti. Il tentativo si è arenato in sede parlamentare e non se ne è fatto più niente. Cosa ci insegnano le due vicende? E’ in atto a livello globale una ridefinizione dei rapporti tra Poteri dello Stato che si vorrebbe in favore del Potere esecutivo, in Italia, e, in altri Stati, dei vertici degli apparati: la vicenda degli Stati uniti è emblematica di questa “globalizzazione istituzionale”. Per quanto riguarda la Corte dei conti europea, che è competente per l’esame di tutti i conti relativi alle entrate e alle spese dell’Unione, e quella italiana è evidente l’insofferenza per i controlli svolti da queste due Istituzioni. Difficile dire, quindi, quale potrà essere il loro ruolo e gli auspici valgono ben poco in quadro politico di grave incertezza quale quello attuale.
8. La nuova governance economica europea sembra porre al centro il principio delle riforme strutturali orientate al raggiungimento di obiettivi misurabili, creando un legame diretto fra risorse e risultati. A suo avviso, tale logica è compatibile con il sistema italiano sia dei controlli, sia delle responsabilità (specialmente, amministrativo-contabile)?
 La nuova governance economica europea, come è noto, individua gli assi portanti nel “Piano strutturale di bilancio”, che individua il “percorso della spesa netta” e la “traiettoria di riferimento”. Si tratta di un pacchetto di misure (due regolamenti e una direttiva) definite alla fine del mese di aprile dello scorso anno. Nella audizione parlamentare del 7 maggio 2024, la Corte dei conti è stata sentita sugli aspetti concernenti la coerenza costituzionale delle nuove regole finanziarie europee. Il nuovo quadro che ne risulta è senz’altro, in tesi, compatibile con la “cultura del risultato”, simboleggiata dalle tre E (efficacia, efficienza e economicità) che è appannaggio – sin dal 1994 – della Corte dei conti, a cui fa riferimento il controllo successivo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, prima ancora che il principio del risultato trovasse la sua consacrazione nel Codice dei contratti pubblici (versione 2023). Altra cosa è, invece, la reale attuazione di tale modello di controllo e qui vengono le note dolenti, in quanto è dalla fine del secolo scorso che si assiste in termici numerici ad una diminuzione dei controlli sulle gestioni pubbliche in sede regionale, essendo il personale di magistratura e i revisori impegnati a svolgere a tappeto i controlli contabili-finanziari.
La nuova governance economica europea, come è noto, individua gli assi portanti nel “Piano strutturale di bilancio”, che individua il “percorso della spesa netta” e la “traiettoria di riferimento”. Si tratta di un pacchetto di misure (due regolamenti e una direttiva) definite alla fine del mese di aprile dello scorso anno. Nella audizione parlamentare del 7 maggio 2024, la Corte dei conti è stata sentita sugli aspetti concernenti la coerenza costituzionale delle nuove regole finanziarie europee. Il nuovo quadro che ne risulta è senz’altro, in tesi, compatibile con la “cultura del risultato”, simboleggiata dalle tre E (efficacia, efficienza e economicità) che è appannaggio – sin dal 1994 – della Corte dei conti, a cui fa riferimento il controllo successivo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, prima ancora che il principio del risultato trovasse la sua consacrazione nel Codice dei contratti pubblici (versione 2023). Altra cosa è, invece, la reale attuazione di tale modello di controllo e qui vengono le note dolenti, in quanto è dalla fine del secolo scorso che si assiste in termici numerici ad una diminuzione dei controlli sulle gestioni pubbliche in sede regionale, essendo il personale di magistratura e i revisori impegnati a svolgere a tappeto i controlli contabili-finanziari.
9. La crescente complessità dei processi decisionali nella spesa pubblica, specie in ambito europeo, ha reso evidente la difficoltà di individuare univocamente il centro di imputazione delle responsabilità. Come evitare, secondo lei, che la frammentazione tra soggetti attuatori, autorità centrali, enti locali e soggetti privati si traduca in una sostanziale insindacabilità dell’azione amministrativa?
Direi che il problema evocato nella domanda possa trovare facile soluzione, a livello domestico, in considerazione del carattere personalistico della responsabilità amministrativa. Vero è che individuare il “ centro di imputazione della responsabilità” può essere difficoltoso allorquando concorrono alla erogazione di contributi pubblici i vari livelli di governo. Ciò che , però, deve essere sempre tenuto presente in queste fattispecie è che si risponde per ciò che rientra nelle proprie competenze e che anche il privato risponde del danno conseguente alla erogazione indebita di risorse finanziare derivanti dal bilancio dell’Unione.
Parte IV: Le nuove prospettive
10. La sua carriera si è sviluppata lungo molteplici fronti: un percorso poliedrico, che coniuga rigore tecnico e apertura istituzionale. Quali sono oggi, a suo giudizio, le doti fondamentali per un magistrato contabile, chiamato a operare in uno spazio che è sempre più europeo, integrato e ad alta complessità?
Sono entrato in Corte dei conti da giovane magistrato militare e senza, quindi, alcuna pregressa esperienza lavorativa in apparati burocratici della P.A.. Per giunta, come ho già detto, con una formazione universitaria distante dagli studi della contabilità pubblica, tant’è che, a volte, scherzando con gli altri mi definisco un giurista “prestato” alla Corte dei conti. La mia prima assegnazione è stata alla Sezione del controllo di Trento e, poi, ininterrottamente e sino a tutt’oggi sono stato assegnato all’area giurisdizionale, nella quale ho rivestito le funzioni di giudice, di procuratore regionale e, attualmente, sono presidente di una sezione giurisdizionale regionale, oltre che “delegato” al controllo sulla gestione finanziaria di una importante società partecipata dal MEF. Per completare la mia preparazione professionale, su mia richiesta, sono stato assegnato in via aggiuntiva, prima, alla Sezione II di appello e, poi, alla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato. Le doti fondamentali che un magistrato contabile deve avere si fondano su uno studio continuo della contabilità pubblica, che tenga conto delle novità normative ed ordinamentali, senza assecondare la tentazione, che pure è naturale, di abbracciare gli schemi del passato. Non ci sarà, invero, alcun corso di aggiornamento che possa sostituire lo studio individuale. Il passo ulteriore è applicare quello che si è imparato alla attività di propria competenza, tenendo conto della dimensione costituzionale e sovranazionale dei problemi della finanza pubblica.
11. E quali insegnamenti potrebbe trarre dalla sua esperienza, da trasmettere alle nuove generazioni di magistrati?
L’insegnamento che ho tratto dalla mia esperienza professionale risente molto dei valori che mi sono stati trasmessi in famiglia e degli incontri e dei dialoghi che ho avuto con persone che hanno lasciato un segno profondo nella mia vita; tra questi voglio ricordare Nicola Rana, che mi ha insegnato tanto sul piano umano. Nonostante il ricambio generazionale credo che siano importanti per un magistrato la libertà e l’indipendenza, tra loro connesse. Solo chi è libero, infatti, può essere indipendente e, non da meno, chi è indipendente non può che essere libero.
Ha scritto Luigi Ferrajoli: “Ogni giudice e ogni pubblico ministero incontrano, nella loro lunga carriera, migliaia di cittadini: come imputati, come persone offese, come testimoni, come attori o convenuti. Naturalmente non ricorderanno quasi nessuna di queste persone. Ma ciascuna di queste persone ricorderà quell’incontro come un’esperienza esistenziale indimenticabile. Indipendentemente dal fatto che abbia avuto torto o ragione, ricorderà e giudicherà il suo giudice, ne valuterà l’equilibrio o l’arroganza, il rispetto oppure il disprezzo per la persona, la capacità di ascoltare le sue ragioni oppure l’ottusità burocratica, l’imparzialità o il pre-giudizio.il senso di umanità oppure l’inerzia e l’insensibilità. Ricorderà, soprattutto, se quel giudice gli ha fatto paura o gli ha suscitato fiducia. Solo in questo secondo caso ne avvertirà e ne difenderà l’indipendenza come una sua garanzia, cioè come una garanzia dei suoi diritti di cittadino”.
Mi sento, pertanto, di dire alle nuove generazioni di magistrati (non solo) contabili: siate sempre liberi da ogni condizionamento e battetevi senza limiti per conquistare la vostra indipendenza.
Credetemi, ne vale la pena.
Il pdf dell’intervista è scaricabile al seguente link: Intervista Pres. Raeli
